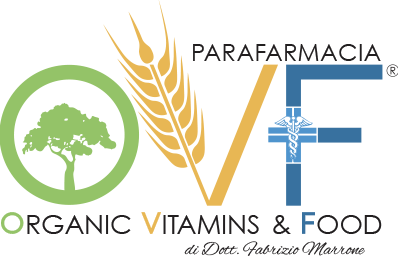PFAS: le sostanze chimiche “eterne” che stanno contaminando acqua, ambiente e salute
Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono composti chimici sintetici introdotti negli anni ’40 e utilizzati in una vasta gamma di prodotti di consumo, dai rivestimenti antiaderenti e i tessuti impermeabili ai sistemi di refrigerazione e persino agli inalatori per l’asma. Queste molecole sono caratterizzate da una straordinaria stabilità chimica che ne impedisce la degradazione: una volta rilasciate nell’ambiente o assorbite dal nostro organismo vi rimangono per lunghi periodi, generando quello che oggi viene definito “inquinamento eterno”.
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha registrato una diffusione globale delle PFAS. Secondo l’Environmental Protection Agency (EPA), il 45% delle acque potabili negli Stati Uniti contiene PFAS. In Europa, un’indagine dell’associazione Que Choisir ha documentato la presenza di queste sostanze in trenta città francesi. Un rapporto della Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) ha identificato concentrazioni di PFAS in 55 campioni di acqua potabile prelevati in undici Paesi europei, con valori medi pari a 740 ng/l nell’acqua di rubinetto e 278 ng/l nelle acque minerali.
Per quanto riguarda il nostro Paese, una rilevazione condotta da Greenpeace su 235 città italiane ha evidenziato la presenza di PFAS nel 79% dei campioni di acqua analizzati. Dal gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo limite massimo consentito (100 ng/l), che in molte aree rischia già oggi di essere superato.
Le conseguenze per la salute sono ormai ben documentate: in una review pubblicata su Springer Nature, l’esposizione alle PFAS è stata associata a immunotossicità, alterazioni endocrine, danni epatici e aumento del rischio oncologico. Un articolo apparso su Environmental Health Journal ha inoltre evidenziato una correlazione diretta tra presenza di PFAS e variazioni dei biomarcatori enzimatici della funzionalità epatica.
A livello sperimentale stanno emergendo approcci innovativi per la degradazione di queste sostanze. Uno studio ha verificato la capacità di Acetobacterium spp. di attivare processi di defluorinazione riduttiva su acidi per- e polifluorocarbossilici insaturi. Un secondo lavoro, condotto in presenza del batterio Labrys portucalensis F11, ha dimostrato una potenziale biodegradazione di tre composti PFAS (PFOS, 6:2 FTS e 5:3 FTCA) in ambienti contaminati. Altri gruppi di ricerca stanno esplorando la possibilità di ridurre i livelli di PFAS sierici attraverso interventi nutrizionali specifici.
Sul piano politico emerge un quadro preoccupante. Secondo un’inchiesta coordinata dal quotidiano Le Monde (progetto transnazionale Forever Lobbying), le principali aziende chimiche – in particolare Chemours, spin-off di DuPont e produttrice del Teflon – hanno intrapreso attività di lobbying molto aggressive nei confronti delle istituzioni europee. Studi scientifici finanziati dall’industria, strategie di comunicazione coordinate e pressioni sui decisori politici rischiano di ritardare l’introduzione di normative più restrittive. Non a caso, molti osservatori paragonano il caso PFAS a quello dell’industria del tabacco.
Per aiutare i cittadini e i ricercatori a comprendere la vera portata del problema, Le Monde ha realizzato una mappa interattiva che mostra i siti contaminati da PFAS in vari Paesi europei, consentendo una visualizzazione chiara dei livelli di inquinamento e delle aree più esposte.
In conclusione, affrontare la questione PFAS richiede una risposta integrata: maggiore consapevolezza pubblica, sostegno alla ricerca scientifica indipendente, pressioni civiche sui decisori politici e norme rigorose in grado di limitare l’utilizzo di queste sostanze. Solo così sarà possibile interrompere il rilascio delle sostanze chimiche eterne e tutelare la salute delle generazioni future.